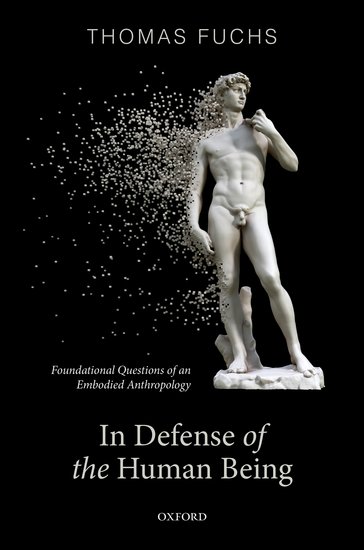 In un’epoca dove tempo e spazio, i due più grandi titani metafisici su cui si sono interrogate generazioni e generazioni di filosofi e scienziati, si sono rivelati dominabili e plasmabili interamente dalla techne, si avverte inesorabile la necessità di chiedersi cosa sia rimasto ancora di squisitamente ‘umano’. Il mondo è alla mercé di un’incredibile de-materializzazione, il corpo umano si sta lentamente vuotando di senso a vantaggio di una sua versione più pura e sublimata, incorruttibile ed incorreggibile: lo spirito artificiale dell’informazione.
In un’epoca dove tempo e spazio, i due più grandi titani metafisici su cui si sono interrogate generazioni e generazioni di filosofi e scienziati, si sono rivelati dominabili e plasmabili interamente dalla techne, si avverte inesorabile la necessità di chiedersi cosa sia rimasto ancora di squisitamente ‘umano’. Il mondo è alla mercé di un’incredibile de-materializzazione, il corpo umano si sta lentamente vuotando di senso a vantaggio di una sua versione più pura e sublimata, incorruttibile ed incorreggibile: lo spirito artificiale dell’informazione.
Così, con queste parole che sanno di laconica amarezza e silenzioso cordoglio, il filosofo e psichiatra di Heidelberg inizia il suo nuovo volume, mandando in apnea il lettore che attende, pagina dopo pagina, di trovare qualche confortante ‘bolla d’aria’ dove non ci sia la promessa attuale (che suona più come una minaccia) di una rivoluzione digitale, tale da annientare in futuro qualsiasi gap tra l’umano e l’artificiale.
Nel primo capitolo, Fuchs analizza i termini chiave dell’era tecnologica: la digitalizzazione del mondo e la simulazione della soggettività. Il primo processo consiste fondamentalmente nella scomposizione del mondo in unità numeriche, algoritmi e segni regolati da principi matematici che si traducono in informazione, considerata dai riduzionisti e computazionalisti l’elemento chiave della coscienza. Il secondo, invece, presuppone l’esatta ricostruzione della soggettività umana come un programma, e la coscienza, ancora una volta, viene raffigurata come un mondo interiore trascendentale segmentabile e riproducibile, trascurando il fatto che essa sia piuttosto l’attività propria di un essere vivente che sente, percepisce e si relaziona con un ambiente circostante. La coscienza non è un “feedback loop” (p. 40) situata nel cervello o in un robot, ma è pura esperienza (Erleben), una peculiare integrazione di sistemi vitali in un unico organismo. È per questo che il termine ‘vita artificiale’ è un paradossale misnomio: non può esserci vita artificiale, poiché la vita stessa non è un prodotto fabbricato o programmato, ma è auto-creazione, attuazione spontanea di se stessa. E finché demandiamo alla tecnologia l’estensione del nostro corpo (che sta subendo comunque un processo di depauperamento vitale, di cui discuteremo più avanti), forse riusciremo a conservare ancora un lembo della nostra imperfetta umanità. Il pericolo più grande risiede nel volere assegnare, sempre di più, decisioni e responsabilità ai sistemi artificiali, decretando così la fine dell’eidos “uomo” e facendo sempre più spazio alle allettanti prospettive della perfezione e dell’eternità.
Tuttavia, commenta Fuchs, qualsiasi forma di biotecnologico perfezionamento delle caratteristiche e abilità umane promuoverebbe la concezione dell’uomo come una macchina manipolabile e ottimizzabile: l’Homo Optimus, in definitiva, prenderebbe il posto dell’Homo Sapiens, riducendo il corpo a materia plasmabile all’infinito, la coscienza a portatrice di nuovi valori e desideri sprigionati da algoritmi e calcoli matematici. Già Dostoevsky aveva brillantemente intuito che “l’essere un umano di carne e sangue inizia ad annoiarci – piuttosto, vorremmo nascere da un’idea” (p. 76), ma trascinati da questa insana fantasia, dimentichiamo che la corporeità radicale della nostra esistenza è totalmente antitetica al progresso digitale, resiste profondamente e dolorosamente a questa trasformazione. Il secondo capitolo, dunque, conclude con un rigetto dell’ideale transumanista, che ambisce all’eliminazione delle contraddizioni e polarità tipiche dell’essere umano, come se “potesse esserci qualcosa come una mente pura, una felicità pura, una conoscenza senza dimenticanza, e una vita senza morte.”
Un altro aspetto piuttosto conturbante della questione è il destino della comunicazione empatica, quella che (come suggerisce l’etimologia della parola stessa) prevede il coinvolgimento inter-affettivo tra due o più individui in una sfera relazionale, dove il corpo proprio agisce come strumento ‘ecoizzante’ di un pathos collettivo. La proliferazione del mondo digitale di segni, immagini e presenze illusorie ha contribuito gradualmente allo sviluppo di un modo diverso di comunicare con gli altri – con la decisiva spinta addizionale apportata dalla recente pandemia di Covid-19. Un modo ‘disincarnato’ di stabilire connessioni interpersonali, che comporta l’impoverimento, se non l’esclusione, dell’elemento veramente costitutivo della comunicazione: la reciproca risonanza corporea. È proprio grazie al contrasto con la comunicazione digitale, afferma l’autore, che possiamo riconoscere cosa significhi esattamente “presenza corporea”: ascolto attivo, percezione dell’espressione altrui, incontro diretto con lo sguardo dell’altro, la possibilità di toccare e di essere toccato, e soprattutto il coinvolgimento atmosferico nella presenza dell’altro, situazione intersoggettiva tra le più intense e totalmente irriproducibile tramite la comunicazione tecnicamente mediata.
Nell’incontro virtuale, dunque, si perde quella ‘coreografia’ comunicativa che anima davvero il processo di comprensione reciproca; quella comprensione che Levinas (cfr. Altrimenti che essere o al di là dell’essenza) situava nel miracolo dell’incontro degli sguardi, dell’apertura di significato tramite la visione del volto dell’altro, di fronte al mio. “Nessuno ci potrà mai incontrare tramite uno smartphone. La presenza virtuale dell’altro non può sostituire l’intercorporeità” (p. 101).
Il quarto capitolo fa da ponte con le posizioni più sentitamente personali dell’autore, che sferza una netta critica al “cerebrocentrismo”, una tendenza in voga negli ultimi anni che fa fede alla supposta corrispondenza tra cervello e soggettività. Non esisterebbe, quindi, un Io quale reticolo immateriale di sensazioni, pensieri ed emozioni, ma solo un cervello pensante, il vero locus della coscienza. Eppure, i neuroscienziati sono soggetti ad un immenso errore categoriale: sono le persone ad essere consce, non i loro cervelli. E la coscienza non è un oggetto localizzabile al quale si può puntare un dito come a qualsiasi altro oggetto fisico: essa è un processo dinamico, relazionale, un continuo potenza-atto che dischiude un mondo. La persona si forma nel e attraverso il proprio corpo, che non è una conchiglia dentro la quale si nasconde ed è dunque solo rappresentata simbolicamente da esso. La neuroscienza si avvale di capisaldi che si sgretolano facilmente di fronte a delle incontrovertibili auto-evidenze, sostiene Fuchs: le tecniche di neuroimaging, per esempio, localizzando nel cervello delle aree dove avvengono più o meno intense attività metaboliche in concomitanza di funzioni o compiti differenti, non hanno svelato la capacità di “leggere i pensieri nel cervello” (J.D. Haynes, Brain reading, in S. Richmond, G. Rees, S.J. Edwards (eds.), I Know What You’re Thinking. Brain Imaging and Mental Privacy, Oxford University Press, Oxford 2012, pp. 29-40), dal momento che le medesime attività metaboliche sono meri indicatori di processi psicologici. Senza pensare che le ricerche sperimentali vengono effettuate in ambienti rigidamente controllati, dai quali si eliminano aspetti fondamentali, come la relazionalità, l’intenzionalità e la temporalità. È l’essere umano a pensare, sentire, ed agire, non il cervello. Ed il fatto che attualmente per le neuroscienze il corpo continui ad essere un mero portatore fisiologico del cervello, è perché non hanno la concezione olistica di esso come un organismo vivente, intrappolate come sono nella visione cartesiana di una mente computazionale, che dirige e registra complessi processi neurali.
Andare oltre questo trend “neuro-metafisico” o cerebro-centrista, come è stato definito dall’autore, non significa di certo congedare ogni interesse o studio critico sul cervello umano, ma ridimensionare ruoli e direzioni: la neurobiologia indaghi pure sull’essere umano, ma non al suo interno, perché i processi neurali non ci dicono nulla su chi siamo, cosa proviamo in un determinato momento, cosa ci rende felici e cosa ci addolora. Ciò che ci costituisce davvero come persone è il nostro legame intercorporeo con il mondo della vita, e il cervello è “solo” la condizione, certamente cruciale, di possibilità di tale legame.
Nel quinto capitolo, la polemica si fa più aspra quando viene posto l’accento sulla questione del processo decisionale: nella prospettiva naturalistica, i processi neurali sono strutturati in maniera deterministica, e l’uomo non può far altro che ciò che il cervello determina. “Le nostre azioni sono chiaramente il risultato di una catena causale di attività neuronali nell’area pre-motoria e motoria del cervello” (P. Haggard, Decision time for free will, in “Neuron”, 69, 2011, pp. 404-406), e dunque tutto ciò che sembra una nostra scelta o decisione, in realtà, è solo un’immensa illusione. Fuchs contrappone al determinismo computazionale il suo concetto di embodied o personal freedom, secondo il quale la mente umana è essenzialmente caratterizzata dalla negazione, dalla capacità di sospendere il reale immediato per vagliare tutte le possibilità fattuali, di fronte anche al rischio della nullificazione. È lo stesso concetto di decisione a presupporre l’esistenza di possibilità alternative per un soggetto, o la presentazione di un futuro verosimile al quale dare o meno il proprio consenso. Il cervello non prende alcuna decisione; al massimo, esso può essere concepito come l’organo attraverso il quale l’organismo per intero ottiene uno spazio di libertà e controllo. Inoltre, la correlazione tra processi cerebrali ed azioni/esperienze non sostanzia in alcun modo il determinismo, dal momento che non vi è riscontro di una rigida corrispondenza su base empirica, anzi, tutto il contrario; vi è decisamente più casualità che linearità, nei test neurobiologici sul cervello umano. La cifra autentica della vita è proprio la sua imprevedibilità, che implica dunque una forma di libertà irrinunciabile, inequivocabile.
La posizione “libertariana” suggerita dall’autore elimina qualsiasi forma di interazione dualistica, in quanto il concetto di libertà incarnata precisa che siamo liberi in quanto soggetti incarnati, e che l’attività della coscienza estrinseca le sue funzioni perché incorporata nell’organismo e supportata da processi fisiologici. Il processo decisionale che conduce ad una scelta, ad un’azione o ad un’esperienza di qualunque tipo, non è una concatenazione di substrati neurali causalmente determinati. Il livello soggiacente i motivi e le ragioni delle deliberazioni umane rimane comunque fisicamente non osservabile perché appartiene alla dynamis della vita stessa, aperta al tutto e al nulla in maniera imprevedibile. Ma nel trovare un compromesso con chi non può rinunciare ad un principio regolatore universale, fosse pure un’idea sbiadita, come quella che possiedono le anime incarnate di Platone una volta precipitate giù dall’iperuranio, Fuchs avvicina cautamente la sua posizione a quella compatibilista, in base alla quale una persona certamente modula e modifica i propri comportamenti in base a ciò che pensa e decide, senza per questo immaginarsi una preistoria o una fiction in cui l’attore abbia differenti personalità con differenti preferenze che lo inducano a una scelta X in un momento Y, e via discorrendo. In un mondo già profondamente obnubilato sulle prospettive future, accondiscendere al determinismo equivarrebbe proprio a congedare per sempre la fiducia nella spontanea creazione, che è ciò di più propriamente umano che ci sia ancora rimasto.
Nei capitoli sesto e settimo prosegue la disamina delle teorie di matrice neuro-costruttivista, le quali assegnano ad ogni cervello la produzione di un proprio ‘spazio virtuale’ che circonda e separa, al tempo stesso. Secondo quest’ottica, nessuno potrà mai comunicare veramente con l’altro, che apparirà quindi come una mera simulazione di alterità. Il punto, sempre dimenticato e negletto, è che anche nell’atto percettivo noi ci troviamo già in uno spazio comune abitato da altre persone, la cui prospettiva garantisce implicitamente la validità della nostra. “Non siamo monadi auto-contenute nel cervello, all’interno del quale viene simulata un’immagine del mondo; piuttosto, noi abitiamo il nostro corpo, e per suo tramite, il mondo” (p.153).
Contro la cecità del riduzionismo neurobiologico, l’Autore sollecita a concepire il soggetto non nella forma di un fantasma prodotto dal cervello, ma come una soggettività incorporata in un corpo senziente e co-estesa con esso. Mai prima d’ora ci siamo trovati a dover riprendere, con un certo impeto emotivo, la definizione di “spontaneità”, di “naturalità” dell’approccio al mondo-della-vita come in questo secolo, nel quale sono molto in voga affermazioni sull’illusorietà prodotta dalla percezione: “il mondo che ci circonda, con i suoi colori ricchi, sfumature, suoni e ombre è solo un’illusione. Se potessimo percepire la realtà com’è veramente, saremmo scioccati dal suo silenzio, dalla sua nudità di colori, odori e sapori”, afferma Eagleman (cfr. D. Eagleman, Incognito. The Secret Lives of the Brain, Pantheon Books, New York 2015), alludendo ancora al cervello come all’unico possibile sceneggiatore della realtà percepita. Come poi riusciremmo a comunicare agli altri le nostre percezioni, se sono semplicemente simulazioni generate dal cervello, rimane una questione irrisolta e volutamente sorvolata. Fuchs invece ci presenta la sua teoria, già discussa in Ecology of the Brain (2018), di “realismo del mondo-della-vita”, imperniata fondamentalmente sull’assunto merleau-pontyano della percezione come, in primis, interazione senso-motoria, che implica necessariamente una forma primitiva di intersoggettività. Infatti, la percezione non significa semplicemente attenzione, ma dipende anche dal movimento nell’ambiente circostante, in cui ricettività e spontaneità si fondono in un processo inseparabile, in cui il cervello funziona fondamentalmente come organo relazionale. Il mondo-della-vita si fonda su una struttura triadica: “Io-Tu-Ciò”, e noi, in quanto membri di una comunità comunicativa, ci relazioniamo all’ambiente non in maniera solipsistica, ma sempre congiunta. Non esiste un oggetto fisico che possa essere percepito indipendentemente dall’esperienza intersoggettiva: la tanto osannata prospettiva scientifica, quella distale della terza-persona, è sempre preceduta dalla prospettiva del noi. “Ciò che sono il cervello, i neuroni, le molecole o gli atomi risulta semplicemente da una condivisa pre-cognizione, da convenzioni e dalla pratica scientifica. Ne consegue che una natura concepita in maniera puramente fisica deve rimanere solo un costrutto teoretico” (p. 173). E non onto-genetico, aggiungo io.
Negli ultimi capitoli, l’Autore lascia parlare il cuore. Si tratta della sua professione, e non solo; di un progetto, una missione, un credo che anima da sempre i suoi scritti e il suo lavoro. Fuchs è uno dei più insigni esponenti della psichiatria fenomenologica, lanciata da Karl Jaspers e magnificamente raccolta e applicata da numerosi specialisti della salute mentale, soprattutto della scuola di Heidelberg. La psichiatria che applica il metodo fenomenologico si astiene dalla classificazione categoriale dei sintomi e predilige un approccio centrato sulla persona, in particolar modo osservando i cambiamenti riportati nel rapporto con il proprio corpo e con il mondo interpersonale. La psichiatria biologica, invece, ricerca le cause in disturbi o compromissioni a livello neuronale o funzionale, che ben si prestano a strumenti di imaging o computer-based, dando quindi lo smacco definitivo alle abilità cliniche e terapeutiche del medico. “Lo psichiatra del futuro saprà senz’altro ogni cosa che riguarda il sistema di reward, ma non saprà più distinguere una schizofrenia da un’isteria” (p. 183).
La psichiatria non deve perdere di vista il centro focale della propria arte, che consiste tutta nella capacità di relazione con un’alterità sofferente, persa, che in primis chiede ascolto e comprensione, e non classificazione e diagnosi.
Il capitolo successivo apre uno spaccato dai toni volutamente delicati sulla questione dell’identità personale nella demenza. Com’è solito, Fuchs riporta prima le teorie più diffuse in merito, per poi decostruirle e ribadire sempre uno dei più importanti capisaldi del suo pensiero: “l’esistenza personale significa principalmente soggettività corporea ed essere vivo, dall’inizio fino alla fine” (p. 211). Contro il concetto del sé come esclusiva articolazione linguistica, narrativa e sociale che vedrebbe la sua totale disgregazione nella malattia di Alzheimer, l’Autore propone una visione incarnata della demenza, che enfatizza le relazioni implicite che il corpo stabilisce con l’ambiente, la nicchia familiare che reca con sé un senso di familiarità e di appartenenza ad un orizzonte confortante. Contrariamente alla prospettiva di matrice lockiana, la nostra identità si compone di strati che vanno ben oltre la nostra capacità di ricordarli esplicitamente; nel nostro habitus, nel nostro essere “carne del mondo”, mostriamo noi stessi come persone non meno di quanto lo facciano le nostre capacità cognitive e riflessive.
A chiosa di questo denso volume, intriso di tutte le note più peculiari del suo pensiero, Fuchs ci invita a ridimensionare anche il valore vissuto del tempo, che la modernità ha trasformato nel veleno dell’esistenza umana, così indaffarata in un’accelerazione sfrenata dei ritmi quotidiani, alla disperata ricerca del soddisfacimento ultimo di desideri sempre più alienanti. Tuttavia, se tornassimo ancora una volta a considerare il corpo, che ci parla in ogni sua manifestazione, vedremmo che esso è principalmente caratterizzato da una struttura ritmico-periodica del presente immediato, caratterizzata da un’alternanza ciclica di carenze, desideri, esaurimento e rigenerazione. Il cosiddetto tempo “ciclico” è radicato nella memoria corporea, nelle sue abitualità e ripetizioni, mentre il tempo “lineare” si sviluppa in concomitanza con la memoria autobiografica, con la consapevolezza di un passato e di un presente, e soprattutto con la prospettiva anticipatoria della morte (p. 231). È proprio quest’ultimo che ha perentoriamente dominato i tempi moderni, creando un’abissale sproporzione tra i due: alcune tra le forme più gravi di mania e depressione sono ascrivibili proprio alla patologica accelerazione del tempo tipica delle società occidentali.
Dunque, osserva lo psichiatra-filosofo, bisogna ricorrere a delle strategie di ritardo e inibizione per permettere anche alle risorse del corpo di rifiorire e rigenerarsi naturalmente. Una di queste strategie potrebbe essere proprio la ritmizzazione della vita, una soluzione straordinariamente semplice quanto effettivamente distante dal nostro modus vivendi attuale: dovremmo, esorta l’Autore, “resistere alla de-ritmizzazione della vita, che si sta estendendo sempre di più a tutte le aree della società. Ad esempio, l’apertura 24 ore su 24, o l’accesso costante ai media, sono i nemici naturali del tempo ciclico, e dunque, umano” (p. 232). Ai nuovi drammi dell’era moderna, che isola e de-umanizza l’uomo creando sempre più disagio e malessere, dovremmo contrapporre sprazzi di spontaneità, ritornare al qui ed ora, alternare fasi di accelerazione a fasi di riposo. Insomma, ogni tanto sarebbe anche opportuno spegnere i riflettori sulle immagini ipostatizzate di noi stessi, e tornare ad osservarci e sentirci come siamo concretamente, in carne e ossa (e dialogo).
mercoledì , 24 aprile 2024
Ultime notizie
- 167. Recensione a: Marcello Barison, Sul concomitante. Metafisica e tecnica della violenza, Meltemi, Milano 2023, pp. 344. (Stefano Piazzese)
- 166. Recensione a: Guido Cusinato, Periagoge. Theory of Singularity and Philosophy as an Exercise of Transformation, trans. by R. Shibuya and K. Whittle, Brill, Leiden 2023, pp. 410. (Fulvia de Luise)
- 165. Recensione a: Antonio G. Balistreri, La scrittura come scoperta, Mimesis, Milano-Udine 2023, pp. 226. (Enrico Palma)
- 164. Recensione a: Alessandro Dondi, Dall’uomo esposto al soggetto esposto. Il concetto di interfaccia in alcuni filoni di riflessione sulla tecnica dal Settecento a Marcel Mauss, Mimesis, Milano-Udine 2023, pp. 410. (Christian Frigerio)
- 163. Recensione a: Giorgio Agamben, Il Regno e il Giardino, Neri Pozza, Vicenza 2019, pp. 128. (Giulia Ruas)
- 162. Recensione a: Donatella Di Cesare, Utopia del comprendere. Da Babele ad Auschwitz, Bollati Boringhieri, Torino 2021, pp. 304. (Francesco Di Marco)
- 161. Recensione a: Luisella Battaglia, Bioetica, Editrice Bibliografica, Milano 2022, pp. 190. (Andrea Allegra)
- 160. Recensione a: Roberto Esposito, Vitam instituere. Genealogia dell’istituzione, Einaudi, Torino 2023, pp. XVIII-150. (Jacopo Moretti)
- 159. Recensione a: Theodor W. Adorno, Problemi di filosofia morale, a cura di Th. Schröder, trad. it. di E. Zanelli, ETS, Pisa 2022, pp. 208. (Lorenzo Biagini)
- 158. Recensione a: Davide Ragnolini, Hyle. Breve storia della materia increata, Rubbettino, Soveria Mannelli 2023, pp. 133. (Alberto Giovanni Biuso)

 English
English

