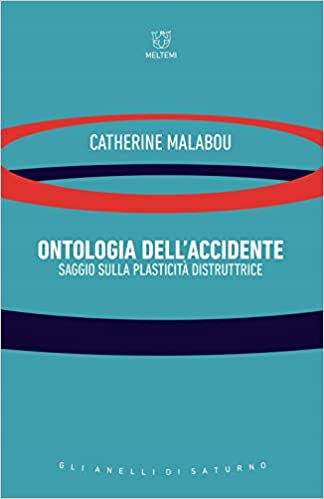 Ontologie de l’accident di Catherine Malabou compare, dieci anni dopo la sua pubblicazione in Francia, anche in lingua italiana e si colloca, potremmo dire, al “posto giusto”. Gli anelli di Saturno, collana della Meltemi diretta da Salvatore Tedesco e dedicata all’Estetica, ai media e ai linguaggi dell’arte, presenta infatti, a partire dalla sua stessa denominazione, il progetto di un percorso, di una narrazione fatta di frammenti, di tracce, di simboli e di costellazioni.
Ontologie de l’accident di Catherine Malabou compare, dieci anni dopo la sua pubblicazione in Francia, anche in lingua italiana e si colloca, potremmo dire, al “posto giusto”. Gli anelli di Saturno, collana della Meltemi diretta da Salvatore Tedesco e dedicata all’Estetica, ai media e ai linguaggi dell’arte, presenta infatti, a partire dalla sua stessa denominazione, il progetto di un percorso, di una narrazione fatta di frammenti, di tracce, di simboli e di costellazioni.
Quella presentata dalla filosofa francese è una riflessione che ruota interamente attorno al tentativo di una puntualizzazione del ruolo di un dato accidente plastico per la creazione di nuove identità formali. Essa assume a tratti un carattere intimistico e si intreccia a frammenti filosofici e letterari, da Spinoza a Deleuze, da Kafka a Duras, che tracciano un’inedita e diffusa ontologia della distruzione che potenzialmente minaccia, e al tempo stesso rende possibile, la vita di ciascuno di noi. Muovendosi attorno alla categoria del plastico, Malabou intende riflettere sulla forma vivente e sulle inevitabili trasformazioni che essa vive nello scorrere del tempo. «Nella maggior parte dei casi le vite seguono il loro corso come i fiumi» (p. 32), per poi divenire, col tempo, finalmente, ciò che si è e nient’altro che ciò che si è. Talvolta, scrive l’autrice, accade che il fiume abbandoni improvvisamente il proprio letto, senza alcun apparente motivo geologico, e sopraggiunga ciò che viene definita una “deflagrazione plastica”. Assimilabile ad un trauma, ad una incrinatura o ad una crisi biologica ed esistenziale; un evento di tale portata può condurre ad una “improvvisazione esistenziale assoluta”, una nuova forma nata dall’accidente, per l’appunto.
Il breve saggio Ontologia dell’accidente può essere letto come una sorta di epilogo ad una lunga trattazione del tema della variazione plastica da parte della filosofa francese – e più strettamente come l’ideale continuazione di un’opera apparsa qualche anno prima intitolata Que faire de notre cerveau? (Cosa fare del nostro cervello?) – posto al cuore dell’indagine del più intimo nesso tra ontologia ed estetica, tra la scienza dell’essere e quella dell’apparire. La plasticità assume in tale contesto il duplice significato del ricevere e del dare una forma in riferimento a tutto ciò che subisce e, allo stesso tempo esercita, tale azione di modellamento. In un circuito pressoché ininterrotto, tutto ciò che è dotato di forma accetta il rischio della trasformazione che coinvolge tanto il nostro essere quanto il nostro apparire e non sempre si verifica in maniera positiva. Al concetto positivo di plasticità si accosta anche la possibilità di un significato negativo che ne intercetta la potenza distruttrice ed esplosiva.
Il concetto di metamorfosi su cui Malabou si sofferma nel primo capitolo si articola in dialogo con la mitologia e con alcuni degli esempi di bizzarrie e trasformazioni narrate da poeta Ovidio, le quali ci consentono di mettere in luce come «la forma improvvisamente deviante, deviata, di queste vite è la plasticità esplosiva» (p. 32). Il tentativo forse più celebre e brillante di descrivere una simile fenomenologia della deviazione si condensa nella pagine de Le Metamorfosi di Kafka. La condizione improvvisa ed inaspettata del povero Gregor Samsa, risvegliatosi una mattina nel corpo di un gigantesco insetto, è l’occasione per riflettere su quei «modi d’essere privi di genealogia» (p. 32) che, in un senso più ampio, riguardano le innumerevoli vite distrutte dal dolore, dalla depressione, dall’isolamento e dalla malattia (un caso particolare è quello dei malati di Alzheimer): vite trasformate e sopravvissute alla distruzione della propria identità. «Nessuno pensa spontaneamente a un’arte plastica della distruzione. Tuttavia, anche quest’ultima configura. Una faccia spaccata è ancora un volto, un moncone è pur sempre una forma, una psiche traumatizzata resta una psiche» (p. 33). Lo sguardo che ci consente di riconoscere una simile «clandestinità esistenziale» (p. 39) riconosce il percorso di una trasformazione radicale, di una «mutazione che coinvolga tanto la forma quanto l’essere, una forma nuova che sia letteralmente forma d’essere» (p. 45).
Il concetto di forma, a partire dagli scritti morfologici di J.W. Goethe, si intreccia con il tema della variazione plastica e con il modello di una trasformazione infinita. Nelle sue digressioni filosofiche, soprattutto a partire dal secondo capitolo, Malabou riferisce una certa modalità del divenire all’idea spinoziana di conatus, indicato come la tendenza di ogni essere vivente a perseverare nel proprio essere nel mutamento e a rispondere alle circostanze esteriori. Ma ci mette ben in allerta dall’individuare, come aveva fatto Gilles Deleuze, la caratteristica essenziale del conatus nella sua elasticità. A suo avviso, il termine “elasticità” non risulterebbe essere il più consono a rispecchiare le esigenze della forma e del vivente, dal momento che ciò che è elastico si caratterizza per la sua capacità di ritornare alla forma iniziale, quella che aveva preceduto la trasformazione, e questo chiaramente non è ciò che accade dopo un evento distruttivo. Il mutamento a cui ci si riferisce con la plasticità distruttrice implica, infatti, «un’ontologia della modificazione» in grado di «accogliere nel suo cuore questo particolare tipo di metamorfosi che corrisponde ad un addio dell’essere a se stesso» (p. 61). Tale addio si realizza nella forma dell’evento, come una rottura improvvisa che spezza la continuità temporale e squarcia il piano di una crisi. Tutti i processi, per quanto lunghi e continui possano apparire, sono frastagliati da accidenti che determinano delle fratture e dei momenti inediti di riconfigurazione. Appare a tal proposito molto interessante la lettura che l’autrice fornisce del fenomeno dell’invecchiamento. Esso, in maniera paradigmatica, rivisto alla luce di quanto detto, «ci insegna che per invecchiare il divenir-vecchio in un certo senso non basta» (p. 65). C’è bisogno di qualcosa di più. Per comprendere appieno l’accadere della vecchiaia è necessario introdurre la sua istantaneità e considerare l’evento scatenante – come un incidente, un lutto, un dolore fisico o psicologico – che improvvisamente ha reso vecchio colui che fino ad un istante prima stava solamente invecchiando. Nella prospettiva di questa concezione «la plasticità caratterizza una trasformazione esplosiva dell’individuo, una pura frattura. La vecchiaia sarebbe rottura e non continuità esistenziale» (p. 65).
La vecchiaia è, usando una metafora letteraria, l’incontro vertiginoso e angosciante tra il tempo perduto ed il tempo ritrovato, quello che esplode improvvisamente una mattina nella quale il narratore Marcel Proust incontra dopo diversi anni le sue antiche conoscenze e le descrive come appena riconoscibili. Tra continuità e rottura, nella «lunga deformazione costituente del divenir-vecchio che procede tramite la sostituzione di ciascuna cellula con un’altra» (p. 73), ci si rende conto di essere già vecchi. Gli anziani della scena di Proust si sono trasformati in personaggi completamente diversi, come fossero mascherati; «essi sono allo stesso tempo le carrellate cinematografiche di se stessi e le istantanee di una metamorfosi assoluta» (p. 74). Plastica è anche l’ambiguità del tempo che procede tra la progressione e l’istantaneità dell’urto e dell’accidente. Secondo tale «ambivalenza ritmica e ontologica del tempo» (p. 77) si rende possibile il paradosso esistenziale di invecchiare prima di invecchiare. Malabou vi dedica delle bellissime pagine e richiama all’attenzione del lettore la figura e le parole di Marguerite Duras, che ne L’amante si descrive come una “giovane vecchia” trasformata brutalmente, improvvisamente e in piena giovinezza in altro da sé. Una vita di violenza e la strada dell’alcolismo sembrano coincidere, nell’esperienza della scrittrice francese, con una ricapitolazione radicale e un invecchiamento brutale che, a soli diciotto anni, viene descritto come un’improvvisa deviazione dei tratti somatici. Lo squarcio sul viso della Duras è l’incipit che separa per sempre il prima e il dopo, la giovinezza dalla vecchiaia, nella forma imprevedibile di un esperimento: «l’accidente – scrive Malabou – è qui la dimensione sperimentale dell’ontologia» (p. 80).
Il sesto ed ultimo capitolo si apre con una domanda, che si tramuta poi in constatazione, di carattere squisitamente ontologico e antropologico. È possibile, per la vita, dire di no a se stessa? Ovvero dire «no alla continuità, no alla resistenza della memoria o dell’infanzia, no alla bella forma, no alla metamorfosi sensata, no al declino progressivo, no allo stesso progredire del negativo»? (p. 93). È possibile una plasticità distruttrice? Una simile domanda risuona insieme con la domanda essenziale che Max Scheler formula nel suo studio La posizione dell’uomo nel cosmo e alla quale risponde affermando che l’uomo è “colui che sa dire di no alla vita”, colui che ha la possibilità di viverla eccezionalmente e altrimenti. Un tale possibile negativo non è da intendersi come la negazione del possibile, o come una sua forma deficitaria; esso testimonia «un potere o un’attitudine del negativo che non si afferma né difetta, che forma» (p. 94).
Il rapporto tra Morfologia e plasticità, costantemente richiamato nel corso del saggio, viene messo a punto nella Postfazione di Salvatore Tedesco, il quale definisce Ontologia dell’accidente come un’opera in grado di offrirci «uno sguardo inedito e irrinunciabile sulla questione della forma, uno spazio prezioso per la riflessione morfologica del nostro tempo» (p. 108). Gli obiettivi filosofici di una teoria della forma solidarizzano con quelli di una ontologia dell’accidente e si concentrano su una sorta di “zona limite”, di soglia concettuale ed esistenziale che emerge nella deflagrazione plastica, in quello che Malabou definisce plastiquage dell’identità. Qui l’accidente inverte un intero ordine delle cose e infrange la linearità dell’essere e dell’identità in nuove forme che appaiono nella loro mostruosità. Una tale fenomenologia morfologica si configura come una forma di fuga legata ad una impossibilità di fuggire. Da qui il tentativo, l’esperimento della riconfigurazione. «La tradizione morfologica che in tal modo viene in luce vede nella crisi, nella cesura, nello scardinamento della continuità, addirittura nell’autodistruzione, il cardine attorno a cui ruota l’indagine delle forme» (p. 115). Essa accompagna la sostanza teoretica del saggio sulla plasticità distruttrice e aiuta a comprenderne fino in fondo e forse per la prima volta – merito che a quest’opera possiamo di certo assegnare – le potenzialità della sua azione.
sabato , 27 luglio 2024
Ultime notizie
- 176. Recensione a: Giovanni Cerro, Tra natura e cultura. Degenerazione, eugenetica e razza in Giuseppe Sergi (1841-1936), ETS, Pisa 2024, pp. 326. (Giovanni Frascà)
- 175. Recensione a: Enrico Palma, De Scriptura. Dolore e salvezza in Proust, Mimesis, Milano-Udine 2024, pp. 270. (Sarah Dierna)
- 174. Recensione a: Günther Anders, Opinioni di un eretico, pref. di S. Velotti, Mimesis, Milano-Udine 2023, pp. 95. (Filippo Adussi)
- 173. Recensione a: Giovanni Giorgini, Introduzione al pensiero politico classico, il Mulino, Bologna 2024, pp. 288. (Federico Casella)
- 172. Recensione a: Federico Avogadro, Ernst Cassirer, l’ultimo illuminista 1874-1945, Carocci, Roma 2024, pp. 302. (Giovanni Frascà)
- 171. Recensione a: Eugenio Mazzarella, Contro Metaverso. Salvare la presenza, Mimesis, Milano-Udine 2022, pp. 142. (Sarah Dierna)
- 170. Recensione a: Benedetta Piazzesi, Del governo degli animali. Allevamento e biopolitica, Quodlibet, Macerata 2023, pp. 256. (Miriam Borgia)
- 169. Recensione a: Chiara Agnello, Una ontologia della tecnica al tempo dell’Antropocene. Saggi su Heidegger, InSchibboleth, Roma 2023, pp. 179. (Alberto Giovanni Biuso)
- 168. Recensione a: Alberto Giovanni Biuso, Zdanov. Sul politicamente corretto, Algra Editore, Viagrande-Catania 2024, pp. 157. (Sarah Dierna)
- 167. Recensione a: Marcello Barison, Sul concomitante. Metafisica e tecnica della violenza, Meltemi, Milano 2023, pp. 344. (Stefano Piazzese)

 English
English

