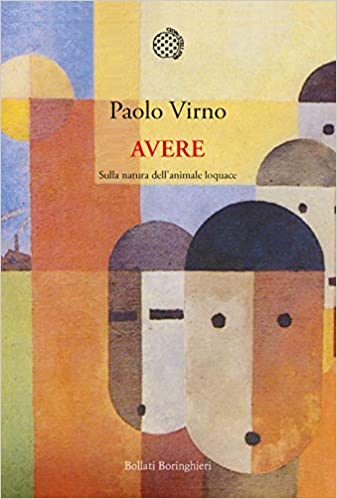 Gli ultimi anni testimoniano di uno spostamento, in filosofia, dall’accento posto sull’essere a quello posto sull’avere, dell’inclinare dell’ontologia verso un’autentica echologia – basti pensare alla crescente influenza di teorici come Gabriel Tarde, Gilles Deleuze e Bruno Latour. Pubblicato nel 2020 da Bollati Boringhieri, Avere. Sulla natura dell’animale loquace può intendersi come una delle più originali declinazioni di tale tendenza. Questa lunga riflessione, perfetta summa del matrimonio di antropologia filosofica, metafisica, filosofia del linguaggio e filosofia della storia che da sempre caratterizza la produzione di Paolo Virno, incentra l’indagine sulla singolarità dell’animale umano, sul verbo avere e sulla peculiare creazione di non-coincidenze che esso determina: “Il verbo ‘avere’ mette in risalto la parziale autonomia dei significati che correla, ovvero la loro refrattarietà ad amalgamarsi al punto da risultare indiscernibili” (p. 11); esso costituisce una “modalità del distacco, dell’appartenenza senza fusione, del possesso basato sulla eterogeneità di possessore e posseduto” (pp. 35-36). Questo scollamento ne fa la differenza rispetto al verbo essere, operatore di una perfetta coincidenza tra i propri termini: “Il verbo ‘avere’, a differenza di ‘essere’, esprime una relazione di appartenenza che esclude risolutamente l’identità tra i termini in essa coinvolti” (p. 14). È insomma una parte della nostra essenza – il possesso del linguaggio verbale – a determinare la relazione che intratteniamo con questa stessa essenza: “umano è l’animale che ha (e non è) la facoltà di parlare” (pp. 37-38), che ha e non è la propria essenza, che è sempre posto a una certa distanza da questa e può pertanto maneggiarla. Il punto d’approdo di Virno non è in fondo troppo distante da quello di Plessner: l’animale parlante è caratterizzato da un’eccentricità, da una mancata coincidenza con sé stesso che dissemina il suo ambiente di vuoti, di interstizi, che sono lo spazio in cui propriamente si configura l’umano nell’uomo. Per questo “[n]on ‘io penso’, ma ‘io ho me stesso’ è il fondamento ultimo non solo e non tanto di una eventuale teoria della conoscenza, ma anzitutto della forma di vita della nostra specie” (p. 131).
Gli ultimi anni testimoniano di uno spostamento, in filosofia, dall’accento posto sull’essere a quello posto sull’avere, dell’inclinare dell’ontologia verso un’autentica echologia – basti pensare alla crescente influenza di teorici come Gabriel Tarde, Gilles Deleuze e Bruno Latour. Pubblicato nel 2020 da Bollati Boringhieri, Avere. Sulla natura dell’animale loquace può intendersi come una delle più originali declinazioni di tale tendenza. Questa lunga riflessione, perfetta summa del matrimonio di antropologia filosofica, metafisica, filosofia del linguaggio e filosofia della storia che da sempre caratterizza la produzione di Paolo Virno, incentra l’indagine sulla singolarità dell’animale umano, sul verbo avere e sulla peculiare creazione di non-coincidenze che esso determina: “Il verbo ‘avere’ mette in risalto la parziale autonomia dei significati che correla, ovvero la loro refrattarietà ad amalgamarsi al punto da risultare indiscernibili” (p. 11); esso costituisce una “modalità del distacco, dell’appartenenza senza fusione, del possesso basato sulla eterogeneità di possessore e posseduto” (pp. 35-36). Questo scollamento ne fa la differenza rispetto al verbo essere, operatore di una perfetta coincidenza tra i propri termini: “Il verbo ‘avere’, a differenza di ‘essere’, esprime una relazione di appartenenza che esclude risolutamente l’identità tra i termini in essa coinvolti” (p. 14). È insomma una parte della nostra essenza – il possesso del linguaggio verbale – a determinare la relazione che intratteniamo con questa stessa essenza: “umano è l’animale che ha (e non è) la facoltà di parlare” (pp. 37-38), che ha e non è la propria essenza, che è sempre posto a una certa distanza da questa e può pertanto maneggiarla. Il punto d’approdo di Virno non è in fondo troppo distante da quello di Plessner: l’animale parlante è caratterizzato da un’eccentricità, da una mancata coincidenza con sé stesso che dissemina il suo ambiente di vuoti, di interstizi, che sono lo spazio in cui propriamente si configura l’umano nell’uomo. Per questo “[n]on ‘io penso’, ma ‘io ho me stesso’ è il fondamento ultimo non solo e non tanto di una eventuale teoria della conoscenza, ma anzitutto della forma di vita della nostra specie” (p. 131).
Avere denota insomma quella che Virno, rifacendosi al classico dibattito sulle relazioni, chiama una relazione estrinseca, una relazione che escluda la coincidenza tra i due termini: scardinando la forma soggetto-predicato della logica classica, avere porta in primo piano “la relazione come tale, mentre la posizione dei termini correlati, in linea di principio mobile e intercambiabile, risulta alla fin fine irrilevante” (p. 23). Il gioco mobile dei termini si sostituisce alla subordinazione degli “accidenti” a una “sostanza prima”. A un pensiero sostanziale se ne sostituisce uno preposizionale: generalizzando la tesi di Benveniste che, nei linguaggi privi del verbo avere, la sua funzione sia nondimeno svolta dalla forma essere a, Virno sostiene che “la forma logica dell’avere consiste nel verbo ‘essere’ unito a, e vincolato da, qualsiasi preposizione” (p. 26). Al modello unico dell’inerenza si sostituisce la molteplicità dei modi d’essere estrinseci: essere a, essere presso, essere tra, in, per…
È questa la via di valico dalla grammatica alla metafisica. Il verbo avere fonda la forma antropologica della méthexis platonica, vera “partecipazione preposizionale” (p. 27). Cessa quella contraddizione, quell’apparente impossibilità di una conciliazione che non inneschi un regresso infinito, che il Parmenide stabiliva tra separatezza e partecipazione; il chorismòs è anzi prodotto dalla méthexis, la perseità delle idee è successiva e dovuta al distacco causato dal verbo avere: “introducendo la non-identità nella concreta fisionomia delle attitudini biologiche e delle occasioni storiche appartenenti all’animale umano, la méthexis procura a ciascuna di queste attitudini e occasioni l’aspetto impersonale, nonché la radicale autonomia, che convengono alle idee” (p. 108). Le facoltà, le potenze proprie dell’uomo che sono da sempre un terreno di riflessione privilegiato per Virno – si pensi alla memoria ne Il ricordo del presente, al general intellect nella Grammatica della moltitudine, al linguaggio in E così via, all’infinito – assurgono al rango di entità autonome a partire dal linguaggio stesso: “Le idee non preesistono alla partecipazione, ma ne sono il risultato. Più precisamente: esse scaturiscono, come un effetto indiretto e però abbagliante, dal prelievo utilizzante di ciò che si ha. Le prerogative e le esperienze che possediamo assumono la forma di idee allorché vi prendiamo parte usandole” (p. 97). Non abbiamo idee che sono; ma sono solo quelle idee che anzitutto abbiamo. Se i dualismi di cui l’animale parlante abbonda sono dovuti proprio al verbo avere (p. 154), l’Uno che si può predicare dell’umano e che supera tanto quest’orda di dualismi quanto la disseminazione di individui atomici è proprio questo iperuranio antropologico che offre un bacino comune di facoltà da cui attingere gli oggetti creati-posseduti dall’avere: “L’autentico monismo […] è il possesso unitario di requisiti dissonanti e talvolta antitetici. Monistico è un vivente la cui essenza consiste, in primo luogo, nell’avere la propria essenza. Monistico è, per l’appunto, l’avere su cui poggiano i dualismi e che dai dualismi è rivelato” (p. 160).
Se questa metafisica preposizionale costituisce il culmine speculativo del libro, Virno non risparmia una quantità di suggestioni meritevoli di riflessione in direzioni disparate. Si potrebbero citare le eccentriche pagine dedicate alla doppia essenza di Cristo, che ha natura umana quanto divina (capitolo 5), o quelle, bellissime, che indagano su base verbale il fenomeno dell’amicizia: “Il sentimento dell’amicizia si radica nella relazione che l’animale umano intrattiene con le sue prerogative essenziali (facoltà del linguaggio, neotenia ecc.) e le sue esperienze biografiche (lavori, abitudini, amori, fallimenti ecc.). Una relazione caratterizzata dallo scarto duraturo che separa i termini correlati. Una relazione di non-identità, che trova nel verbo ‘avere’ il suo portavoce” (pp. 77-78).
Soprattutto, l’accento posto sull’avere permette di spostare l’attenzione dagli stati alle azioni: in quelli che diventano i prolegomeni a ogni futura grammatica prasseologica, “[l]a relazione estrinseca tra possessore e cosa posseduta, espressa da ‘avere’, obbliga il possessore ad agire nei confronti della cosa posseduta: più precisamente, lo obbliga ad attingerla e a utilizzarla, insomma a prendervi parte” (p. 92). Da échein deriva in fondo anche héxis, la disposizione o abitudine, che non si intende se non come una facoltà di agire in un certo modo in determinate condizioni: essere abituati a qualcosa significa poterlo usare, averlo a disposizione, e se l’uomo è faber è perché, prima ancora di costruire, il possesso della possessione, con lo spazio di libertà costituito dallo iato che inserisce tra i due termini, gli permette in qualche modo di usare le proprie facoltà e finanche, foucaultianamente, di usare il sé, di porsi a distanza da esso per praticarlo come un esercizio: “Usiamo soltanto ciò che abbiamo, mai ciò che ci è consustanziale al punto da non riuscire a distinguercene” (p. 14).
Il possesso del possesso implica anche per l’uomo un vero compito ontologico. Già Aristotele nella Metafisica suggeriva che uno dei sensi dell’avere fosse quello di reggere, di sostenere un peso o un onere, come dei pilastri hanno un architrave. Questo senso di sforzo sfocia nell’ulteriore declinazione dell’échein, la necessità di trattenere – kathéchein – il pieno dispiegamento di quanto si possiede: allora, “non sussiste più differenza alcuna tra ‘avere’ e ‘trattenere’” (pp. 149-50). Tale pratica di contenimento costituisce una delle principali forme della phrònesis, della sapienza pratica. Se serve trattenere, è perché l’essenza corre il perpetuo rischio d’essere invasa da ogni caratteristica che possiede. Il verbo avere tenta continuamente di convertirsi in essere, il posseduto cerca di raggiungere la piena coincidenza col possessore, ed è solo l’interstizio aperto dall’avere stesso che permette di operare su questa tendenza frenandola. Anche la potenza di non – per usare un’espressione di Agamben – implica una fatica. Vigilare sull’appropriazione dell’essenza da parte di ciò che le è proprio, questo il compito antropologico per eccellenza: “La mancata compenetrazione dell’animale linguistico con la sua essenza comporta che questo animale tenga a bada e delimiti i requisiti essenziali che nondimeno lo definiscono. Non c’è prerogativa saliente dell’Homo sapiens che non tenda a travolgere il vivente cui inerisce. Difendersi dalla propria essenza è un modo prestigioso di averla e di parteciparvi” (p. 150).
Approcciare la metafisica a partire dall’antropologia diventa per Virno il modo di reinserire una speculazione coraggiosa nell’alveo di una profonda e decennale riflessione sulla singolarità dell’“animale loquace”. Il di fuori dell’uomo, ciò che lo trascende e che non pare in alcun modo riconducibile a lui, si dimostra null’altro che “l’esteriorità dell’interiore” (p. 183), prodotto di quella facoltà, troppo umana ma con ripercussioni sull’interezza dell’essere, che fa l’unicità di una creatura. Il tutto a partire da un piccolo verbo.
giovedì , 25 aprile 2024
Ultime notizie
- 167. Recensione a: Marcello Barison, Sul concomitante. Metafisica e tecnica della violenza, Meltemi, Milano 2023, pp. 344. (Stefano Piazzese)
- 166. Recensione a: Guido Cusinato, Periagoge. Theory of Singularity and Philosophy as an Exercise of Transformation, trans. by R. Shibuya and K. Whittle, Brill, Leiden 2023, pp. 410. (Fulvia de Luise)
- 165. Recensione a: Antonio G. Balistreri, La scrittura come scoperta, Mimesis, Milano-Udine 2023, pp. 226. (Enrico Palma)
- 164. Recensione a: Alessandro Dondi, Dall’uomo esposto al soggetto esposto. Il concetto di interfaccia in alcuni filoni di riflessione sulla tecnica dal Settecento a Marcel Mauss, Mimesis, Milano-Udine 2023, pp. 410. (Christian Frigerio)
- 163. Recensione a: Giorgio Agamben, Il Regno e il Giardino, Neri Pozza, Vicenza 2019, pp. 128. (Giulia Ruas)
- 162. Recensione a: Donatella Di Cesare, Utopia del comprendere. Da Babele ad Auschwitz, Bollati Boringhieri, Torino 2021, pp. 304. (Francesco Di Marco)
- 161. Recensione a: Luisella Battaglia, Bioetica, Editrice Bibliografica, Milano 2022, pp. 190. (Andrea Allegra)
- 160. Recensione a: Roberto Esposito, Vitam instituere. Genealogia dell’istituzione, Einaudi, Torino 2023, pp. XVIII-150. (Jacopo Moretti)
- 159. Recensione a: Theodor W. Adorno, Problemi di filosofia morale, a cura di Th. Schröder, trad. it. di E. Zanelli, ETS, Pisa 2022, pp. 208. (Lorenzo Biagini)
- 158. Recensione a: Davide Ragnolini, Hyle. Breve storia della materia increata, Rubbettino, Soveria Mannelli 2023, pp. 133. (Alberto Giovanni Biuso)

 English
English

